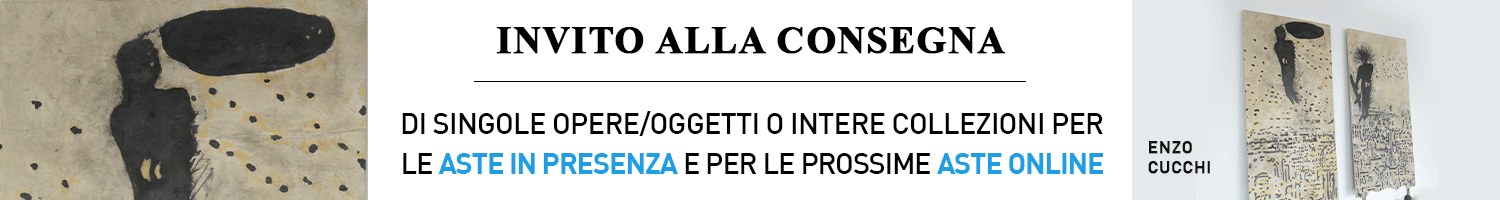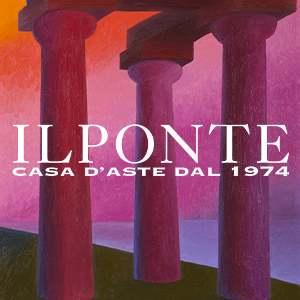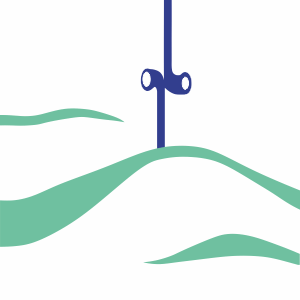“TRILOGIA MILANESE”
IL NOVECENTO A MILANO
Parte I – La Collezione negata
(premessa storica alla visita del Museo del ‘900)
A casa dei miei nonni, talvolta, arrivava una signora con l’occhio veloce, la parlata precisa e essenziale. C’era tutto un affannarsi per accogliere l’ “ospite di riguardo” nel migliore dei modi, il che era complesso, perché l’appartamento era stipato di carte, cartelline (anzi: “carpette”), fotografie, appunti, ritagli, graffette, nastro adesivo, colla (la Coccoina, quella con il pennelletto nel barattolo di latta), penne, matite, giornali, riviste e libri in ogni possibile angolo o superficie d’appoggio, divani, poltrone e sedie compresi; e mio nonno si disperava ogni volta che qualcuno spostava una pila di fogli, stravolgendo le coordinate della sua cartografia casalinga. La nonna teneva molto a questa signora e si dannava per preparare un the come si deve con i biscottini di Novara incartati in coppia della Camporelli e risistemare in qualche maniera il velluto un poco sofferto del divanone impiccato in stile barocchetto veneziano, acquistato – come quasi tutto il parco mobilio – con i primi stipendi di sostanza a Siena, quando mio nonno fu professore straordinario della cattedra di Igiene dal 1938 al 1942.
Un po’ perché abitavo nel palazzo accanto e spesso ero da loro, un po’ perché la nonna voleva che “qualcuno della famiglia” fosse presente per mostrare consapevolezza dell’importanza dell’ospite, in due o tre occasioni anch’io presenziai alle visite di Mercedes Garberi Precerutti (“la Precerutti”, la chiamava mio nonno, in modo un po’ antico, e aggiungeva un sorrisetto di cui solo lui sapeva il significato). Ma la mia partecipazione si limitava al saluto di prammatica e a un convenevole a cui – si vedeva bene – la signora era poco interessata, tutta presa dall’ansia di poter discutere liberamente di artisti, opere, prestiti e “questioni di musei”.
Del resto, io non sapevo che ruolo davvero avesse, la Garberi Precerutti, nella Milano degli anni ’70-’80 del secolo scorso e, quand’anche ne fossi stata consapevole, poco me ne sarebbe calato.
Sono, però, una persona fortunata. Anche per il fatto di aver incrociato lo sguardo acuto e senza velature della signora Garberi, Direttrice per un buon trentennio delle Civiche Raccolte d’Arte di Milano, colei che mosse e smosse con vigore e intraprendenza la cultura della Città negli anni in cui Montanelli stilettava i vizi della borghesia meneghina, il suo conformismo engagé e i suoi salotti chiusi e, tutto sommato, asfittici. E, difatti, non era amatissima.
Oggi, mi pare, ci si vanterebbe di aver stretto altre mani, incrociato altri rai. E la faccenda mi sembra ancora a mio vantaggio…
Ma i miei nonni non frequentavano salotti, e la Garberi neppure.
Mercedes Garberi parlava con loro dei comuni amici Boschi Di Stefano, suoi vicini di casa in Via Jan a lei molto cari, e della donazione al Comune di Milano della loro straordinaria quadreria con appartamento annesso. La Direttrice Garberi presentò la raccolta (delle cui oltre 2000 opere andava curando la schedatura) in una magnifica selezione del 1974 a Palazzo Reale, confidando che – alla lontanissima dipartita dell’ingegnere e all’apertura al pubblico della casa museo – una parte almeno dell’esuberante lascito sarebbe stato trasferito in una sede sentita tanto necessaria quanto chimerica, il Museo di Arte Contemporanea di Milano.
E la Garberi si adopera quindi per questa impresa, capendo che una metropoli come Milano non poteva essere priva del ponte culturale verso la contemporaneità di cui si vantava invece nelle arti della finanza, nelle eccellenze dell’industria e nelle raffinatezze dell’emergente terziario. Nel 1984 riesce ad aprire, al secondo piano di Palazzo Reale, che fu già palcoscenico dei fervori innovativi di Fontana e dell’arte informale e astratta del secondo dopoguerra, una sede “temporanea” del CIMAC (Civico Museo di Arte Contemporanea). Il progetto, difatti, era di inaugurare in seguito un grande Museo nel vasto livello sottostante, perfetto per ospitare le ricche collezioni milanesi del ‘900.
Ma qui inizia la triste storia della Milano “pubblica”, incapace di mantenere le promesse, confidente nel tempo che avrebbe fatto dimenticare gli impegni presi, impegnata a mantenere uno status quo modesto e senza programmi né professionalità che tutt’oggi persiste, malgrado alcuni preziosi (quanto rari) tentativi di emergere.
La collezione Boschi Di Stefano, dopo la presentazione del 1974 e una seconda fugace apparizione “selezionatissima” per poche settimane nel 1997 al PAC, scomparirà al mondo e sarà visibile solo nel 2003.
Difatti, Casa Boschi, invece di essere Museo come il lascito avrebbe imposto dopo la morte dell’Ingegnere nel 1988, ospitò (“temporaneamente”) qualche ufficio del burocrate di turno, indi divenne una sorta di sito senza dignità patria, sino a che una Fondazione costituita anche dagli esasperati eredi nel 1998 obbligherà con una vertenza giudiziaria il Comune di Milano a dare seguito alle disposizioni testamentarie, s’incaricherà della ristrutturazione degli spazi cercando di integrare il mobilio originale, in parte svanito, con arredi d’epoca e finalmente riuscirà a mostrare quel tesoro d’arte nel 2003. Sindaco Albertini, Assessore Daverio, Maggiorenti vari, tutti in prima fila ad attribuirsi il successo dell’impresa invece di genuflettersi di fronte ai cittadini per aver sottratto loro ciò che loro era dovuto da tempo.
Nel desolante quadro di assenze, sarà importante sottolineare che un’altra cospicua rappresentanza della storia del collezionismo meneghino del secondo dopoguerra, quella che fa capo alla raccolta Jesi, fu “ospitata” in un corridoione della Pinacoteca di Brera, dove il lascito del 1976 diventa visibile (per così dire) nel 1981 e dove, confesso, inorridita per lo splendido Soffici del 1914 collocato (“temporaneamente”) ad altezza di struscio di zaino e per l’impossibilità di vedere nella luce infame le opere poste a quote impossibili, preferii mai ritornare sino al 2004 quando fu predisposto un più adeguato allestimento per le opere del XX secolo a cui, nel 2000, si era aggiunta la sofferta donazione dell’eclettica collezione Vitali.
Ma Brera è Sovrintendenza e quindi Stato e, per l’Italia – ove far trasmigrare da un piano all’altro anche un cestino per la carta straccia è questione di sofisticatissima mediazione diplomatica -, trattasi di un altro emisfero.
Nel 1979, l’inarrestabile Garberi riesce a riaprire, dopo anni di chiusura, il PAC, Padiglione d’Arte Contemporanea a fronte della GAM di Via Palestro, dove, nell’ottica di creare un sistema del Contemporaneo adeguato alla Città, organizza con straordinaria energia qualificate mostre temporanee nell’ideale mappa del ‘900 milanese che allineava l’asse di “regalità civica” Villa Reale in Via Palestro/Palazzo Reale in Piazza del Duomo. A due anni dall’inaugurazione, la Direttrice vi presenta la collezione Vismara, donata al Comune nel 1975 alla morte di Giuseppe Vismara, e la porta in GAM in attesa di farla confluire nel futuro grande CIMAC di Palazzo Reale.
Anche la collezione Jucker, acquisita dal Comune nel 1992, strappandola a Brera, fra innumerevoli polemiche e sconcertanti ingiustizie legittimate, è inviata alla Galleria d’Arte Moderna di via Palestro, sempre in via provvisoria, ça va sans dire.
Ma vedere entrambe in questi anni è sempre stata impresa improba.
La postazione “temporanea” del CIMAC viene chiusa nel 1998 per restauri senza che si trovasse la volontà politica di arrivare al dunque: il “titanico” spostamento al piano inferiore, in sale più adeguate e spazi più consoni alla raccolta formatasi sotto l’egida dell’infaticabile Signora dell’arte pubblica milanese.
Le speranze di inaugurare un grande Museo d’Arte Contemporanea in Piazza Duomo cominciano ad affievolirsi. Dopo il 1998, una parte delle opere sono trasferite al Museo della Permanente di Via Turati; altre prendono strade diverse e, fra un’incompetenza, una colpevole omissione, un ostacolo poco casuale e un affaire del politicume più retrivo, Milano non avrà più davvero il suo ‘900 nazionale e internazionale sino a oggi.
Palazzo Reale diventa un insipido contenitore di mostre di cassetta che solo ogni tanto riesce a risollevare la testa (ad esempio, con la recente mostra “Sacro Lombardo”) e i pochi capaci che potrebbero mutarne il triste destino (come Paolo Biscottini, oggi soddisfatto responsabile del colto e rinato Museo Diocesano) lo abbandonano, frustrati dall’immobilismo asburgico che lo contraddistingue.
Il PAC, teatro di un attentato in cui persero la vita cinque persone nel luglio del 1993, chiude per la ristrutturazione, con ampliamento per la caffetteria, a opera dello stesso Ignazio Gardella il quale per costruirlo di bel nuovo sull’area delle Scuderie di Villa Reale bombardate durante la guerra impiegò il medesimo arco temporale: tre anni, dal 1951 al 1954. Dopo la riapertura del 1996, l’attività frenetica ed entusiasta dei primi due decenni (150 mostre nel primo!) è solo un vago ricordo, anche se, fortunatamente, le manifestazioni sono ancora di discreto livello con qualche occasionale punta.
Mercedes non è più, da tempo, responsabile di questo sfacelo.
Una vita per una causa e una causa persa alla fine della propria carriera.
La stessa causa che infiammava i discorsi con mio nonno, che del“la Precerutti” aveva stima, e con cui collaborò per tante mostre. Ma l’aria milanese della fine degli anni ’80 era di fronda: la Città non sentiva, come alcuni suoi cittadini esemplari, la necessità di essere Contemporanea e neppure Moderna.
La contemporaneità assorbita tutta dall’invasione rutilante del mondo della moda “che tanti posti di lavoro crea” e di quello del design, il quale, dopo lo scoppiettìo degli anni ’90, sembra aver già esaurito lo sprint, accantonate le regole di alta progettualità/funzione/qualità dei materiali/produzione seriale (e economica) che informavano le idee dei grandi nomi del ‘900 per arrivare all’ “illustritudine” di oggetti perlopiù inutili, inutilmente costosi e, spesso, inutilmente a tiratura limitata. L’eccellenza da onorare è visibile al Museo della Triennale che una sapiente direzione in poco tempo ha reso moderno, efficiente e importante in Italia e all’Estero. Caso rarissimo a Milano, a riprova che conta assai più un singolo agguerrito di un manipolo di imbelli.
Ma non ci sarebbero lagnanze e reprimende, se ci fosse spazio per tutti.
La deriva culturale che contraddistingue gli ultimi quindici anni di vita politica milanese allontana dal capoluogo lombardo i collezionisti che ancora si ritrovano nel solco degli Jesi, Jucker, Vitali, Vismara e Boschi Di Stefano.
Straordinaria è la pervicacia (per non dire cocciutaggine) con cui i protagonisti di cui sto per parlare cercano per anni un dialogo con le istituzioni meneghine e, malgrado l’offensiva, indisponente cecità delle stesse, riescono – in un modo o nell’altro – a rendere pubbliche e visibili le loro proprietà.
Nel 1974 la vedova di Lucio Fontana offre al Comune di Milano una grande donazione. Mercedes Garberi, come sempre, l’aiuta a realizzare la mostra di presentazione delle opere a Palazzo Reale, ma di tutto ciò rimane solo il catalogo. Il Comune non “trova posto” per l’artista italiano del XX secolo più noto al mondo che potrebbe a ragione pretendere un Museo dedicato, e il lascito non è perfezionato. Teresita Rasini Fontana costituirà quindi una Fondazione privata in nome del grande Spazialista nel 1982. Fortunatamente, a Milano. Ma sarebbe benemerita ovunque.
Nel 1990 Arturo Schwarz offre due terzi (circa 800 titoli) della sua collezione del Dada e del Surrealismo alla sua città di adozione, a cui è legatissimo. Nel 1992 il Comune lascia cadere ogni trattativa e ogni possibilità d’intesa con il grande studioso.
Vale la pena di riportare, in proposito, l’intervista che Viviana Kasam fece a Schwarz nelle pagine del Corriere della Sera del 23 febbraio 2003 a proposito dell’incredibile e sofferto pellegrinaggio delle opere.
Collezionista, poeta, raffinato uomo di cultura, Arturo Schwarz, ebreo egiziano ma milanese di adozione («arrivai profugo nel ’49, senza una lira») ha donato alla Galleria Nazionale d’arte moderna di Villa Giulia […], parte della sua collezione di arte dada e surrealista: 400 pezzi su 1200 […]. Come mai Roma, e non Milano? «E’ stata una transazione difficilissima, durata quasi vent’anni. Il mio desiderio era di donarla per intero allo Stato italiano, cui sono molto grato. Ma quando la offrii, l’allora ministro Bono Parrino mi rispose indignata: “come osa proporre allo Stato opere anticlericali, sovversive, pornografiche?”». Schwarz si rivolse allora al sindaco di Milano Pillitteri, che si dichiarò entusiasta, ma non concluse nulla. Provò con il successore Borghini «che non rispose». Decise allora di donare tutto a Israele. A quel punto diventò ministro Alberto Ronchey, che «riesumò» la pratica e chiese a Schwarz di lasciare in Italia una parte della collezione. Ronchey non riuscì a concludere, i successori nemmeno, finché arrivò al ministero Veltroni che «il giorno dopo la nomina mi scrisse per dirmi che entro un anno la collezione sarebbe stata accolta alla Gnam. E così fu». Ma lei è legato a Roma? «A me piace Milano. E’ più piccola, più a mia dimensione. Le metropoli, anche Parigi, New York, non sono consone al mio temperamento. Però Roma è bellissima, mi piace venirci in visita».
Nel 1997 la Collezione Mattioli, nell’indifferenza degli Enti cui era stata per anni offerta, si rifugia a Venezia presso la Fondazione Guggenheim, dove acquista una visibilità internazionale che sarebbe piaciuta a Gianni, papà di Laura Mattioli, oggi storica dell’arte, il quale affittò in Via Senato uno studio per esporla al pubblico ogni domenica mattina sino alla sua morte. Il povero Assessore Carrubba, appena arrivato in giunta con grandi speranze di poter utilizzare le sue pur notevoli qualità professionali e intellettuali, inerme spettatore del pessimo lavoro altrui, confida nel semper erigendo CIMAC e il fresco di nomina, solo quella, Museo del Presente (come per un certo periodo venne definito il museo della stretta contemporaneità, da collocarsi alla Bovisa) e si dice certo che dopo i primi sei anni di deposito in laguna la Collezione Mattioli ritornerà in patria. La realtà, come tutti sappiamo, è diversa.
La Collezione del conte Giuseppe Panza di Biumo (una parte dell’immensa Collezione Panza), dalle caratteristiche differenti nei contenuti ma non nello spirito delle “colleghe” della generazione precedente, prese il largo, dopo i vani tentativi del proprietario di far comprendere a ottusi funzionari di mezza Italia (Milano compresa: era previsto un copioso lascito per le cascine del Parco Forlanini) che l’arte americana poteva ben comparire da noi, e dopo il rifiuto dei consiglieri leghisti di Varese di ricevere in dono, affinché fosse Museo Civico, un’intera villa zeppa di opere “straniere” adducendo che, essendo il Guggenheim di New York partner culturale, il sito poteva risultare l’impropria vetrina di mostre non italiche (magari, addirittura, non “padane”…).
E, così, nel 1996 il conte dona al FAI la splendida magione con le opere che tutti i grandi critici internazionali ritengono frutto della scelta di una delle più raffinate menti collezionistiche del XX secolo. Mentre una bella e vasta selezione di arte minimalista passa in deposito nel 1997 al MART di Gabriella Belli, quando ancora la sede museale era a Palazzo delle Albere a Trento, ma la Direttrice ispirava una tale fiducia e una tale trascinante capacità decisionale che aspettare il MART di Rovereto (nel 1997 ancora in fase di completamento progettuale e nel 2002 già inaugurato!) non sembrava un problema. E poiché Giuseppe Panza di Biumo aveva un fiuto eccellente e un’instancabile dedizione all’arte, la collaborazione con il Museo fu proficua, duratura e appassionata. Cosicché noi possiamo godere di quello che rimane di una collezione che, fuori d’Italia, ha costruito interi siti espositivi e dipartimenti specialistici intorno alla propria meritatissima fama.
Infine, parte della raccolta di Claudia Gian Ferrari, figlia di Ettore, gallerista eccezionale, promotore di Corrente e responsabile dal 1942 al 1968 (quando fu abolito) del Settore Vendite della Biennale di Venezia (era possibile acquistare le opere delle Biennali i cui autori acconsentivano alla vendita), viene destinata ancora al FAI, che nel 2001 riceve in lascito dalle eredi Villa Necchi Campiglio, in pieno centro a Milano. Nel 2008, dopo il restauro delle sobrie ed eleganti architetture del Portaluppi, si apre la Villa al pubblico arricchita della collezione d’arte del ‘900 della gallerista milanese che con ciò intendeva onorare i propri genitori.
Un altro nucleo di arte contemporanea della Gian Ferrari vola invece al MAXXI di Roma, che, gratissimo per il lascito e affamato di opere per la propria collezione permanente, intitola alla benefattrice milanese una delle sette aree espositive della strabiliante architettura hadidiana inaugurata nel giugno 2010. Di questo meritato riconoscimento Claudia non potrà godere perché mancherà, proprio in questi giorni, lo scorso anno a soli 64 anni d’età.
All’ormai consueta domanda sul perché una tale collezione, frutto di una cultura tutta milanese nell’internazionalità delle scelte, nell’acutezza dello sguardo e nel desiderio di condivisione, non fosse destinata alle raccolte civiche, con la tranquilla e pungente schiettezza che la distingueva in un mondo di acrobatiche ipocrisie, Claudia Gian Ferrari risponde che, pensando sin dal 2003 alla sua collocazione, non vedeva a Milano possibilità di asilo in un museo millantato da troppo tempo e, soprattutto, non gradiva il progetto di Italo Rota all’Arengario poiché snaturava la linea delle severe architetture muziane, intervenendo pesantemente sulle strutture originali.
In corner, la gallerista donerà poi al capoluogo lombardo il suo importante Archivio dei maestri del XX secolo (che costituirà il fondo principale di documenti del futuro Museo del ‘900) e la biblioteca d’arte della galleria.
Può bastare, come chaier de doléances?
E i miei longevi nonni, che c’entrano? Avvertito l’incolto vento milanese degli anni ’90, osservata la desolazione della Garberi, verificata l’indifferenza delle istituzioni nei confronti del collezionismo e il trattamento riservato alle donazioni e ai depositi dei loro amici, decidono insieme alle figlie di essere garantiti dalla qualità del lavoro del MART e nel 1997, insieme al Conte Panza, primi dei molti che seguiranno (ad oggi più di 120 fra lasciti, depositi e archivi) inviano a Trento le opere della loro collezione (Augusto e Francesca Giovanardi), contese fra gli anni ’50 e inizi ‘80 a colpi “mortali” con i loro amici/antagonisti nelle gallerie Barbaroux, Bergamini, Gian Ferrari, del Milione di Bardi prima e Ghiringhelli poi, Annunciata, Grossetti, Cavallino e nella casa d’aste Finarte di Gian Marco Manusardi, poi diretta dal genero Casimiro Porro.
Si consuma intanto una sottile damnatio memoriae di Mercedes Garberi, mancata nel gennaio del 2007, che quasi neppure compare nel cataloghino del Museo Boschi Di Stefano di cui dovrebbe invece essere l’onorata madrina, così come sembra quasi assente nel ricordo della costruzione di una collezione d’arte moderna e contemporanea straordinaria, accumulata con frenetica attività per l’unico scopo di fornire a Milano una raccolta pubblica d’arte del XX secolo degna del nome della metropoli che sostiene essere la più internazionale d’Italia.
E’ con la collega che le succede alla Direzione delle Civiche Raccolte d’Arte di Milano, Maria Teresa Fiorio, la quale nel 2003 passerà Soprintendente negli uffici di Brera, che prende forma il progetto di fare dell’Arengario il tanto sospirato Museo del ‘900, abbandonando così, definitivamente, l’assai più logico (e ampio) sito di Palazzo Reale.
La Fiorio, di indubitabili meriti culturali coltivati perlopiù nello studio dell’arte italiana dal Cinque al Settecento e con il vantaggio di aver conosciuto “le due facce della barricata” milanese (il settore civico e quello statale), consiglia lo spazio dell’Arengario all’Assessore Carrubba, il quale annuncia insieme al vice sindaco Riccardo De Corato, in un’affollata conferenza stampa del 17 dicembre 2003, il progetto vincitore per la riqualificazione dell’edificio come Museo d’Arte Moderna di Milano. Il progetto, già finanziato, è dell’architetto Italo Rota e il Museo vedrà la luce esattamente sette anni dopo.
Nel 2002, Maria Teresa Fiorio, che in Carrubba (e De Corato) troverà un buon interlocutore, ha già potuto avviare la ristrutturazione di Villa Reale a Palestro, nella cui area museale sarà destinata la quadreria ottocentesca. Sembra – malgrado gl’infiniti ostacoli di una Milano pubblica e privata incapace di comprendere il valore di queste operazioni – che l’antico disegno di Mercedes Garberi riprenda forma, almeno parzialmente. Ma Villa Reale rimarrà per anni ancora la GAM e ospiterà, nel modo che Luca Zuccala su Arslife ha obiettivamente, amorevolmente, tristemente descritto, le collezioni d’arte del XX secolo Jucker, Vismara e Grassi (che spazia però dal Cinquecento al Novecento, passando per l’Impressionismo francese).
Per qualche mese fra il 2002 e il 2003, però, il miracolo impossibile della comunione d’intenti fra Stato e Comune è realtà: molto fu fatto in quel poco tempo e fu decisivo per arrivare a oggi.
Nota della scrivente al quadro Carlo Carrà, Nuotatori, 1932 , esposto nel gennaio 1933 alla Galleria Pesaro di Milano, già collezione Valdameri, poi Collezione Frua,infine, a metà anni ’50, Collezione Giovanardi. L’opera non è a Milano, bensì al MART di Rovereto, e non è posta per capriccio o per indebito vanto in testa a questa addolorata narrazione dei casi che condussero nell’arco di una trentina d’anni alla frammentazione della solida identità culturale milanese, determinante per la ricostruzione del dopoguerra, iniziata simbolicamente l’11 maggio del 1946 con la riapertura del Teatro alla Scala – bombardato nell’agosto del 1943 – e l’emozionante concerto diretto da Arturo Toscanini, che per l’occasione si convinse a tornare in Patria da un esilio volontario durato quindici anni.
Uomini di parte pubblica e di parte privata sentivano l’importanza etica della cultura come indispensabile fondamento di civiltà senza affannarsi intorno a ciò che si dovesse fare (e a chi dovesse prenderne merito), ma – in puro spirito meneghino – individuando come fare per risorgere presto, ben fermo e sicuro lo scopo.
Questo quadro rappresenta, per me, il Novecento italiano. La perfetta costruzione, l’armonia formale e la sapiente libertà del gesto sintetizzano il retaggio assimilato degli stili che furono e l’anticipazione, quasi inconsapevole ma già percepita, di quelli che saranno, la discussione altissima sul compito dell’arte e sul mestiere dell’artista, mantenendo centrale il rapporto con l’Antico che non dovrebbe mai essere destituito, soprattutto in Italia, della dignità di essere forza propulsiva per ciò che noi oggi definiamo “contemporaneo”.
Non è vero che tutta l’arte è stata contemporanea, come afferma con diversi intenti Maurizio Nannucci nella sua installazione del 1999 alla GAM di Torino, frainteso slogan del qualunquismo diffuso fra i critici italiani dei nostri tempi. Questo concetto toglie autorità al giudizio, pone sul medesimo piano di valori ogni prodotto artistico solo perché frutto di un determinato perimetro cronologico, il che non è, se concediamo al termine “contemporaneo” quel senso di a-temporalità che indica ciò che avanza irrompendo nel futuro e che anticipa i modi della società che verrà.
Del resto, non essendoci presente, ma solo un fluire di attimi passati che attendono di divenire, l’arte contemporanea non può davvero essere l’arte del presente, se non per convenzione. E Nuotatori ben interpreta questa dimensione del potere dell’arte sull’uomo.
Certa arte fu più contemporanea di altra . Certa arte intuì evoluzioni che, al momento della prima codificazione, non erano affatto percepite come contemporanee, anzi erano ritenute estranee ai canoni anche delle avanguardie. Si deve alla misura del giudizio colto se oggi ci permettiamo un ragionamento “moderno” su Caravaggio, perché 400 anni fa qualcuno decise che Caravaggio era più attuale anche del suo tempo, superando le resistenze dell’epoca. Se non ci fosse stato giudizio, ma opinioni indistinte, immotivate e lasciate ai più, Caravaggio sarebbe stato dimenticato.
Sironi era più “avanti” dei suoi colleghi del primo Futurismo, che pure esprimeva inedite urgenze teoriche e formali. Solo il giudizio colto permise a Sironi di sopravvivere a se stesso e alla Storia e fece capire quali infinite matrici racchiudesse la sua opera e quali possibilità avrebbe aperto all’astrattismo e alle correnti informali del nostro Paese.
Questo quadro, infine, incarna ciò che la mia famiglia mi ha regalato in termini di sensibilità, attenzione, attaccamento per l’immenso valore che rappresenta la Cultura e l’Arte per l’Uomo. Io ci credo.
La mia modesta “trilogia milanese”, dura e forse troppo intollerante con le pur inevitabili cadute di tutti noi, è dettata solo dall’amore per una Città che merita molto di più di ciò che ha e che è oggi.
Le code davanti all’ingresso del Museo del ‘900 e quelle per le brutte e banali mostre di questi giorni (e dei mesi e anni passati) provano non che il cittadino è incolto, ma, anzi, che ha voglia di apprendere. E se le mostre che tanto fanno scalpore, perché in titolo recano furbettamente un nome di richiamo, sono in realtà scorrette e deludenti, non ci si erga sprezzanti a difesa dell’errore solo perché tanti biglietti furono strappati. Ci si dovrebbe anzi dolere di aver perso l’occasione, visti i molti accorsi, di aver fatto un buon lavoro. L’ audience non è sempre indice di buona qualità, ma la buona qualità, in genere, garantisce una cospicua audience e possiede il prezioso vantaggio di elevarci a uno stadio di conoscenza superiore.
La mia speranza, per il nuovo Museo, è che si ricominci dal “buon lavoro”.
Cosa che un tempo Milano sapeva e insegnava agli altri come saper fare.
________________________________________
“Trilogia milanese”: Il Novecento a Milano
“Trilogia milanese”: Il Novecento a Milano
Parte III – ALLAAAARMI! – Eleonora Brigliadori alla GAM?
(L’epigono di Mercedes Garberi)